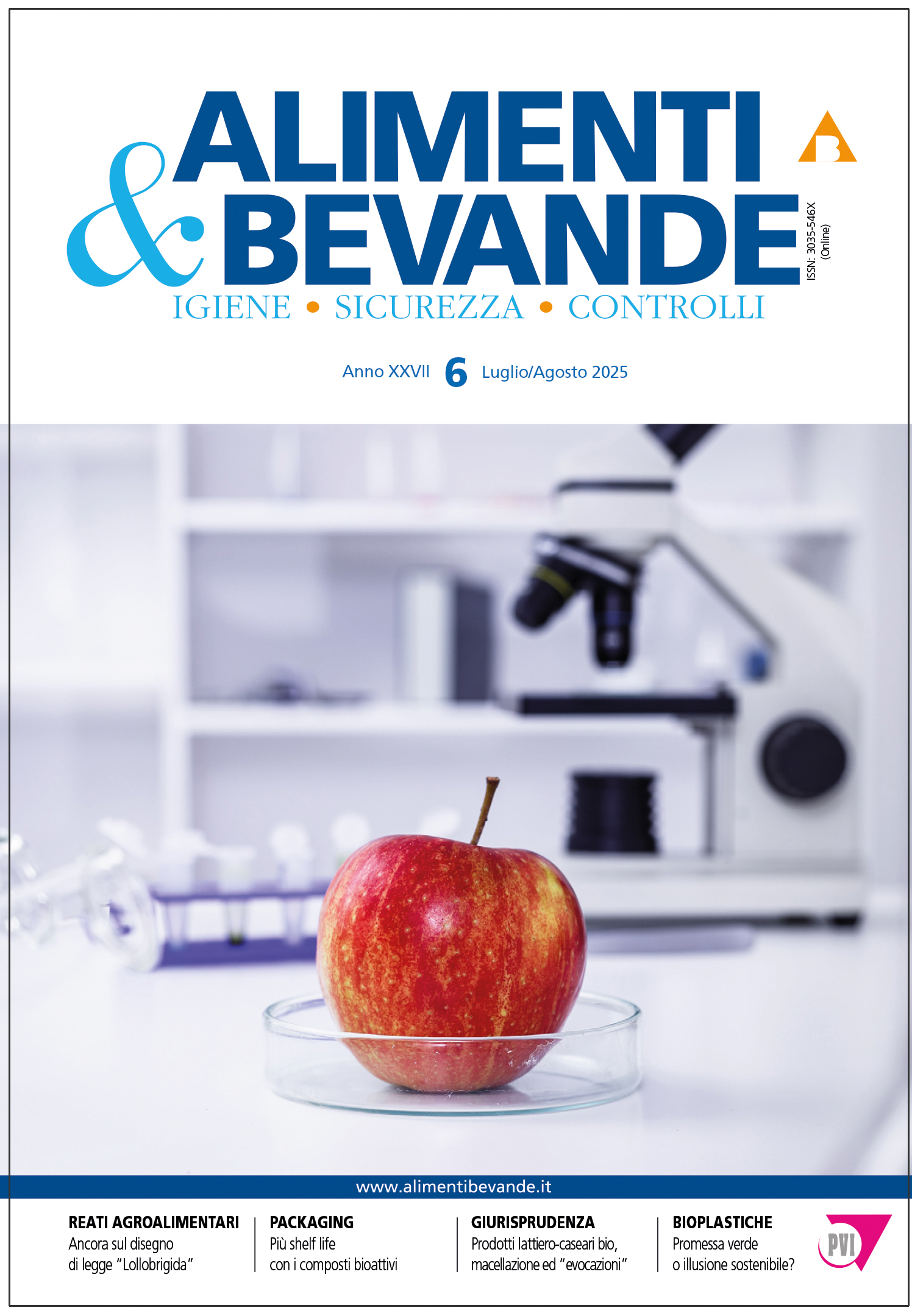L'etichettatura alimentare è un percorso complesso, paragonabile a una "selva oscura", che richiede la conoscenza e l'applicazione di normative europee e nazionali. Le aziende devono integrare competenze interne e supporto esterno per rispettare le regole e costruire etichette conformi e corrette. Ogni elemento dell'etichetta - dalla quantità netta alla dichiarazione nutrizionale, dai claim volontari alla grafica - è regolamentato. È fondamentale partire dalla normativa per evitare errori e costruire messaggi chiari e veritieri per il consumatore.
L'etichettatura alimentare è un percorso complesso, paragonabile a una "selva oscura", che richiede la conoscenza e l'applicazione di normative europee e nazionali. Le aziende devono integrare competenze interne e supporto esterno per rispettare le regole e costruire etichette conformi e corrette. Ogni elemento dell'etichetta - dalla quantità netta alla dichiarazione nutrizionale, dai claim volontari alla grafica - è regolamentato. È fondamentale partire dalla normativa per evitare errori e costruire messaggi chiari e veritieri per il consumatore.
"Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura" che si chiamava etichettatura. Malgrado l'aver scomodato inopportunamente il Sommo Poeta, la citazione del suo celeberrimo verso è quanto di più calzante nella descrizione del percorso che spesso le aziende alimentari si trovano ad affrontare nello studio dell'etichetta degli alimenti che producono, dovendo accordare veramente una "selva" di normative. D'altro canto, basta fare un tour tra i banchi e gli scaffali di un fornito supermercato per scovare imprecisioni, omissioni e acrobazie linguistiche nell'etichettatura alimentare, che si rivela tanto più difficile quanto più l'alimento è il risultato di una processazione complicata e magari con una formulazione ricca di ingredienti.
Ogni azienda giustamente adotta proprie strategie per soddisfare il fabbisogno di competenza nella preparazione dell'etichetta, quali attività formative in ambito regolatorio avanzato, tali da rafforzare la preparazione delle funzioni interne. Oppure utilizza le competenze di consulenti e studi legali esterni, cui demanda l'approvazione di un'etichetta con un vero e proprio "visto si stampi".
Ma tra la progettazione di un alimento e il "visto si stampi" della relativa etichettatura c'è tutto un percorso da svolgere che coinvolge varie funzioni aziendali, dal commerciale al marketing, dalla progettazione e sviluppo alla produzione, fino alla qualità e regolatorio, che spesso ha l'ingrato compito di bloccare un progetto o un'etichetta perché non conforme alla normativa. Probabilmente il punto di partenza più corretto è proprio quello di partire dalle norme, individuando subito i vicoli ciechi e focalizzandosi su cosa si può dire e come si può raccontare un certo prodotto. Quando ci si riferisce all'etichettatura, infatti, è limitativo considerare solo l'adesivo che si applica sul prodotto o il riquadro della confezione in cui sono stampati, ad esempio, ingredienti e data di scadenza. L'etichettatura, infatti, comprende l'intero vestito del prodotto, il packaging, in cui campeggiano immagini, vengono posti in risalto pregi e virtù con affermazioni volontarie, i claim, volte ad attirare l'attenzione del consumatore.
Sono diversi gli strumenti che aiutano a rendere meno tortuoso il percorso dell'etichettatura o quantomeno ad organizzare la progettazione dell'etichetta, ma il prerequisito è una piena consapevolezza della normativa applicabile.
Le fonti della normativa
Con la promulgazione del regolamento (CE) 178/ 2002, per chi si occupa di regolatorio nell'ambito agroalimentare è ormai più che consolidata l'abitudine di consultare il sito di pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, da cui estrarre eventuali novità di interesse emesse dal legislatore europeo.
Per quanto svolga un ruolo fondamentale, si commetterebbe un grave errore a ridurre la raccolta normativa dedicata all'etichettatura al solo regolamento (UE) 1169/2011, il cui titolo "fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" in realtà non intende tutte le informazioni da fornire ai consumatori. Di ciò sono ben consapevoli coloro che producono alimenti che ricadono in specifiche normative di settore (normativa verticale), che a volte non sono emanate dall'Unione europea, ma dal legislatore italiano. Alcuni Ministeri del nostro Paese ci hanno abituato a decreti che puntualizzano denominazioni di vendita di certi prodotti e in qualche caso ne disciplinano la tecnologia di produzione. Tanto per fare qualche esempio, in sintonia col periodo dell'anno, si pensi al decreto ministeriale del 22 luglio 2005, poi modificato nel 2017, emesso dal ministero delle Attività produttive e dal ministero delle Politiche agricole e forestali, che, nell'ambito dei prodotti dolciari da forno, fornisce la chiara definizione di "colomba".
Ulteriore sottoinsieme di settore è poi rappresentato da tutto quel paniere di alimenti che rientrano nelle denominazioni protette: in questi casi, il disciplinare di produzione è il documento di riferimento principale, mentre l'etichettatura dell'alimento viaggia quasi su binario unico.
Quando la tecnologia di produzione fa ricorso alla chimica per aumentare le performance del prodotto, l'elenco degli ingredienti si arricchisce di additivi. È bene, quindi, inserire nella raccolta normativa anche la regolamentazione di questi ultimi, che ricade sotto il regolamento (CE) 1333/2008, mentre il regolamento (CE) 1334/2008 si occupa degli aromi e di alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. Data la continua evoluzione di scienza e tecnologia, additivi e aromi sono soggetti ad aggiornamenti nelle modalità d'uso e nelle dosi negli alimenti di destinazione. Prova ne è il recente aggiornamento del dosaggio dei i nitriti e nitrati nei salumi previsto dal regolamento (UE) 2108/2023. Il portale "Food and Feed Information Portal Database" messo a disposizione sul web dalla Commissione europea rappresenta, quindi, un valido strumento da consultare sia per verificare lo stato di approvazione e le condizioni d'uso dell'additivo, sia per sciogliere dubbi in merito all'obbligo di indicazione nell'elenco ingredienti. L'etichetta pulita, ovvero epurata il più possibile degli additivi, è da sempre un desiderata del settore marketing e vendite, che coglie la diffidenza del consumatore a tutto quanto è preceduto dalla lettera E.
La normativa metrologica
"L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell'Unione in materia di metrologia." Così si esprime il regolamento (UE) 1169/2011 all'articolo 11, richiamando la lettera e) del citato articolo 9, che riporta un laconico "quantità netta dell'alimento", rendendo implicito, o meglio, scontato che il fruitore del regolamento conosca la normativa in ambito metrologico. I dettagli riportati nell'allegato IX riguardano la quantità netta, ma non strettamente le modalità di indicazione delle quantità. Anche la quantità di ciò che la confezione contiene reclama un proprio spazio nell'etichetta. Per simboli di unità di misura e cifre, la normativa prevede collocazione e dimensioni dei caratteri in etichetta ben definiti e non casuali. Così, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1980, n. 391 apprendiamo che per i preimballaggi nazionali l'altezza delle cifre va da 2 mm per prodotti fino a 50 g o ml, fino a 6 mm per prodotti oltre i 1.000 g o ml, mentre dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690 apprendiamo che per i preimballaggi CEE la marcatura "e" è un simbolo con precise caratteristiche grafiche e costituisce una sorta di conformità metrologica, opportunamente collocata nel campo visivo della quantità nominale. Insomma, l'indicazione di pesi e volumi è materia per specialisti, spesso collegata ai servizi di verificazione metrologica delle bilance di cui l'industria si avvale.
Lista delle indicazioni obbligatorie
Tabelle o piccole check list home-made possono rappresentare un aiuto nel verificare se sono state riportate tutte le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011, oltre che le particolarità previste dagli allegati o da altra normativa collegabile al prodotto, tra cui le recenti disposizioni in materia di smaltimento degli imballaggi.
La dichiarazione nutrizionale
Talvolta con numeri dalle dimensioni al limite della lettura, spesso affette da errori nelle maiuscole e minuscole per l'indicazione delle unità di misura dell'apporto energetico, le dichiarazioni nutrizionali fanno parte di quel set di indicazioni obbligatorie di più recente introduzione, sempre per merito del regolamento (UE) 1169/2011. Forse James Prescott Joule (1818-1889), nella sua ottocentesca vita da fisico e birraio, non si aspettava di trovarsi citato su mortadelle, focacce ed ogni altro alimento preimballato ottenuto e/o venduto nell'Unione europea. Ma tant'è che il legislatore ha stabilito che il valore energetico sia espresso sia in kilojoule (kJ) che in kilocalorie (kcal), mentre nell'allegato XIV definisce i coefficienti di conversione per il calcolo dell'energia dai nutrienti. La determinazione delle quantità dei vari nutrienti da inserire nella tabella nutrizionale potrebbe comportare un impegno economico per l'operatore del settore alimentare (Osa) in caso di varie formulazioni e laddove la via scelta fosse quella analitica. Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (UE) 1169/2011 legittima la facoltà di procedere mediante calcolo, partendo da «valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati», oppure «a partire da dati generalmente stabiliti e accettati». In questo caso, risulta però cruciale documentare le fonti da cui si traggono questi valori, oltre che ricette e modalità di calcolo, mentre un'analisi nutrizionale a campione comparativa potrebbe costituire una valida dimostrazione della correttezza dei calcoli teorici utilizzati.
Se, da un lato, la presentazione delle indicazioni obbligatore previste all'articolo13 del regolamento tutelerebbe la vista del consumatore con un limite di altezza dei caratteri, applicabile appunto a tutte le indicazioni obbligatorie, il numero di cifre dopo la virgola, piuttosto che dell'arrotondamento dei valori dei nutrienti protagonisti della tabella nutrizionale, sono in qualche modo disciplinati dalle Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale, emesse dal Ministero della Salute nel 2016 (fondate su analogo documento della Commissione europea). Quindi, non più di 2 cifre dopo la virgola (e solo in casi specifici) e regole di arrotondamento aiutano ad impostare la tabella nutrizionale.
Le indicazioni volontarie
Per alimenti che offrono virtù nutrizionali oppure esprimono tradizioni e valori di certi territori, è impossibile resistere dall'enfatizzarne i benefici per la salute o la poesia del luogo che incorporano. Al contrario, arricchire un certo alimento con un ingrediente di alto valore nutrizionale oppure ridurre quelle componenti che disturbano i piani nutrizionali controllati può divenire allo stesso modo oggetto di una notizia da riportare in etichetta. Questo è il campo delle dichiarazioni volontarie, non obbligatorie, ma non prive di regole. Il legislatore europeo ha promulgato regolamenti che limitano e ordinano le affermazioni volontarie, erigendosi a paladino difensore del consumatore, che non può essere illuso, né tantomeno ingannato.
A chi sceglie di inserire un'affermazione volontaria in etichetta spetta l'onere della prova o, meglio, ciò che nei termini tanto sfruttati dai Sistemi di Gestione della Qualità e Sicurezza alimentare potrebbe definirsi validazione del claim. Avere a disposizione un dossier con dichiarazioni di provenienza, analisi con metodi di prova accreditati o dati sperimentali in grado di dimostrare la sostenibilità del claim fa parte degli obblighi del responsabile delle informazioni sull'alimento: una memoria difensiva, cioè, scritta quando ancora non serve presentarla.
Grafica dell'etichetta
Le informazioni al consumatore passano anche attraverso disegni e immagini riportate sulla confezione. Non possono, quindi, passare informazioni errate, né fuorvianti. Se nel packaging è raffigurato un ingrediente presente nell'alimento ecco che lo stesso ingrediente diviene caratterizzante e, quindi, il consumatore deve essere informato della relativa quantità nell'alimento, a meno che non «sia utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione» (come precisa il legislatore nell'allegato VIII al regolamento (UE) 1169/2011).
La distribuzione delle informazioni nel packaging non è né casuale, né lasciata al libero arbitrio del produttore. Il legislatore europeo ha pensato anche a questo, distinguendo un campo visivo inteso come «tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale», da un campo visivo principale ossia «il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica [...]». Lungo il testo del regolamento vengono quindi puntualizzati i campi di collocazione di talune informazioni obbligatorie che è bene mettere a disposizione delle funzioni che hanno l'incarico di progettare un packaging attraente e gradevole.
Con metodo ed opportuni strumenti, il percorso per costruire l'etichettatura di un alimento può divenire meno tortuoso, ma, scomodando di nuovo il Sommo Poeta, è ben lungi dal divenire una "diritta via".