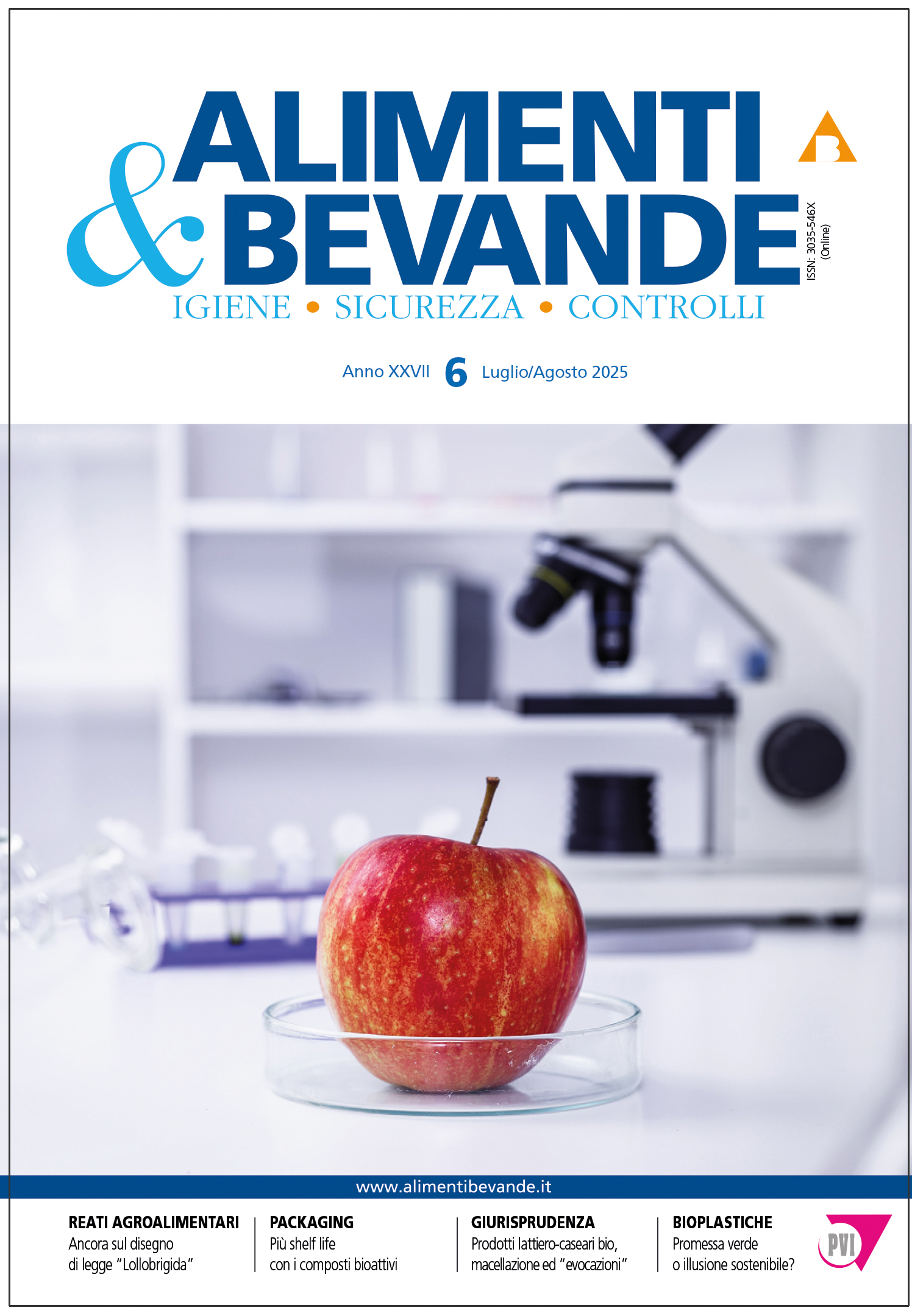Gli alcaloidi sono sostanze organiche azotate in prevalenza di origine vegetale. Gli alcaloidi pirrolizidinici (PAs) hanno ricevuto, e ricevono, maggiore attenzione per la loro presenza all'interno della catena alimentare.
Gli alcaloidi sono sostanze organiche azotate in prevalenza di origine vegetale. Gli alcaloidi pirrolizidinici (PAs) hanno ricevuto, e ricevono, maggiore attenzione per la loro presenza all'interno della catena alimentare.
I PAs comprendono un gruppo variegato di più 660 composti e circa la metà di essi sono responsabili di tossicità acuta o cronica. La loro struttura molecolare è caratterizzata dalla presenza di un gruppo azotato eterociclico, la "necina", e sono presenti in alcuni generi di piante superiori (Hartmann T.,1999), tra le quali le più comuni sono: Senecio (Asteraceae) (Van Wyk Be. et al.,2017), Echium (Boraginaceae) (Bopprè, Colegate e Edgar, 2005), Crotalaria (Fabaceae) (Zhang W. et al., 2017) ed Eupatorium (Asteraceae) (Edgar, Roeder e Molyneux, 2002).
Il contenuto in PAs può variare a seconda della specie vegetale, del tempo di raccolta e delle condizioni climatiche. Da tempo è conosciuta la loro azione epatotossica, nonché la loro attività cancerogena e genotossica negli animali e nell'uomo. In particolare, la loro bioattivazione a livello epatico porta alla formazione di alcaloidi pirrolizidinici 1,2-insaturi, provocando danni al circolo epatico con l'instaurarsi di ipertensione portale come la "sindrome da ostruzione sinusoidale epatica".
Sebbene nella maggior parte dei casi le concentrazioni medie riscontrate siano insufficienti a causare avvelenamento acuto, in alcuni e per determinati alimenti le quantità assunte superano la dose giornaliera massima raccomandata dalle autorità (Tdi), il che potrebbe portare nel lungo periodo all'insorgenza di patologie.
Le piante producono diversi metaboliti primari essenziali per la loro fisiologia e per il loro sviluppo; sintetizzano sia composti organici (proteine, lipidi, clorofilla, enzimi e aminoacidi) e sia inorganici (minerali) che li aiutano nella crescita (Debord C. et al., 2017; Fang C. et al., 2019). Allo stesso modo, hanno sviluppato un ampio ventaglio di metaboliti secondari come meccanismo di difesa (Fang C. et al.2019; Ziegler J. e Facchini PJ., 2008); tra quelli conosciuti, circa 12.000 sono alcaloidi (Ziegler J. e Facchini PJ., 2008) e si possono accumulare in varie porzioni della pianta (semi, infiorescenze, foglie, stelo, radici, nettare e polline).
I PAs sono stati riscontrati nei prodotti di origine vegetale e animale; nell'ultimo periodo, l'attenzione è stata rivolta al miele poiché è il prodotto che più rischia di venire a contatto con tali sostanze per via dell'interazione che le api hanno con le piante; anche gli integratori alimentari con estratti di piante, sia tisane, sia gli stessi alimenti prodotti da animali venuti a contatto con i Pas sono attenzionati (Molineux RJ et al., 2011).
I PAs, una volta introdotti nell'organismo, vanno incontro ad un rapido assorbimento attraverso il sistema gastroenterico e subiscono una successiva metabolizzazione a livello epatico con trasformazione nei rispettivi "N-ossidi", con produzione di derivati pirrolici (metaboliti attivi) ed escrezione per via urinaria e/o biliare (Lin G. et al., 2011).
Relativamente alla loro tossicità acuta, i PAs possono causare agli animali e all'uomo ipertensione polmonare, insufficienza cardiaca, flebopatia veno-occlusiva (VOD). Inoltre, c'è il sospetto che possano avere effetti genotossici, mutageni e cancerogeni (Schrenk D. et al., 2020).
Le piante produttrici di PAs iniziano ad avere un ruolo importante nella sicurezza alimentare; alla luce anche di cambiamenti all'ecosistema ambientale, con l'avanzare sempre più imponente di piante "invasive", si è reso necessario un approccio al problema da parte delle autorità e dei ricercatori, sulla scia del principio di "One Health".
Le principali famiglie botaniche produttrici di Pas
Gli PAs sono metaboliti secondari prodotti da più di 6.000 specie vegetali che fanno capo principalmente a 3 famiglie: Boraginaceae, Asteraceae e Fabaceae. Tra queste, abbiamo piante utilizzate come cibo o culture foraggere e altre che invece sono state definite "infestanti" o "invasive" poiché si sono adattate a un clima e a un terreno differenti dalla loro origine.
Tra le specie appartenenti alla famiglia Boraginaceae, attenzione merita sicuramente la principale rappresentante: la Borago officinalis, inserita nella lista delle piante non ammesse dal Ministero della Salute ai fini alimentari e terapeutici, sebbene si possa usare l'olio estratto dai suoi semi.
Sempre appartenente alla famiglia Boraginaceae, meritano considerazione:
• la Viperina azzurra ossia l'Echium vulgare, considerata una delle maggiori piante mellifere e la principale responsabile della presenza di PAs nel miele europeo (Kast C. et al., 2014). Il suo fiore è stato inserito nella lista degli estratti vegetali non ammessi negli integratori alimentari (www.salute.gov.it; www.cnr.it);
• l'Heliotropium europaeum o anche detto "selvatico", che produce PAs in elevate quantità ed è nota per la sua natura infestante nei foraggi, con elevato riscontro nei mangimi e di conseguenza negli alimenti (Picron JF. et al., 2021). Al genere Heliotropium appartiene anche la specie H. arborescens, detta anche "fior di vaniglia", per il suo caratteristico odore e i suoi fiori viola-azzurri, e considerata una specie alloctona perché originaria del Perù, neofita casuale in alcune zone del Nord Italia.
Passando alla famiglia Fabaceae, la Crotalaria è un genere di piante da fiore nota per la sua tossicità, il cui uso per alimentare gli animali è sconsigliato; infatti, secondo diversi studi, i semi di alcune specie di Crotalaria possono contenere fino al 5% di alcaloidi tossici.
Le implicazioni sulla sicurezza alimentare
Gli animali sono a rischio già al pascolo perché possono imbattersi in un ambiente "povero" di nutrienti, dove magari si fanno spazio le piante "infestanti" che, come succede spesso in natura, non avendo più competitors adeguati che ostacolino la loro crescita, prendono il sopravvento; se di norma quest'ultime sono poco appetibili per gli animali, per un mero discorso organolettico, nel momento in cui si diffondono e diventano l'unico cibo disponibile per il bestiame, gli animali al pascolo finiscono per ingerirle. Negli allevamenti di tipo intensivo, invece, queste erbe "infestanti" possono accidentalmente venire raccolte ed essiccate con il fieno o subire la fermentazione con l'unifeed, finendo nella razione somministrata agli animali.
L'esposizione accidentale agli PAs nell'uomo è similare a quella degli animali, ossia vi è un'ingestione fortuita di erbe; citiamo alcuni esempi riportati in letteratura:
- casi di intossicazione dell'uomo come la contaminazione di cereali con semi di Crotalaria spp. nel 1972 in India;
- intossicazione di massa in Afghanistan per consumo di pane ottenuto da grano contaminato con semi di Heliotropium popovii nel 2008;
- nel 2009 in Germania, dove a seguito della presenza di foglie di Senecio vulgaris nel mezzo di insalata di quarta gamma di rucola (le cui foglie sono simili a quelle del Senecio), vi sono stati casi di ospedalizzazione; a questo episodio è seguito anche un comunicato del Bfr, l'istituto federale per la valutazione del rischio in Germania, che non escludeva che le persone coinvolte potessero avere, in futuro, problemi di cirrosi epatica (www.vitaminabee.it).
PAs nei prodotti di origine animale
Sulla base di alcuni studi (Mulder PPJ. et al, 2018; Mulder PPJ. et al., 2015), i livelli di PAs osservati nelle uova, nelle carni e nei prodotti lattiero-caseari non destano problemi per la sicurezza alimentare poiché il trasferimento nelle derrate alimentari è minimo; alla luce dei dati in letteratura che vedono casi di intossicazione del bestiame al pascolo e dati su una ridotta efficienza produttiva come per l'ovodeposizione, la rimozione delle piante aromatiche sia dai campi per la raccolta del fieno da lavorare sia dai campi usati per l'alimentazione semibrada o brada può essere, però, una soluzione da tenere a mente per la salute degli animali, ma anche per la salute della flora, che risente sempre più della presenza di piante infestanti, spesso tra le più grandi produttrici di PAs che deteriorano l'ambiente e l'ecosistema già fragile per vari fattori esogeni ((Hoogenboom L. et al. (2011); (Mulder PPJ. et al., 2016; Mulder PPJ. et al., 2020)).
PAs nei prodotti dell'alveare
Se la maggior parte degli animali viene a contatto con i PAs in maniera per lo più accidentale, le api si nutrono direttamente dei frutti delle piante, ne raccolgono nettare, polline e altre sostanze resinose dalla flora, tutti necessari per la loro sopravvivenza e per la produzione dei prodotti derivati dall'alveare; il contatto con gli alcaloidi pirrolizidinici è quindi inevitabile. Le api bottinatrici sono il collegamento tra l'alveare e la pianta e, attraverso il loro prezioso lavoro di raccolta di polline e nettare, producono i grandi frutti dell'alveare, nonché prodotti alimentari che ritroviamo nelle nostre tavole.
Gli studi sui prodotti dell'alveare si sono svolti soprattutto sul miele perché è il prodotto più diffuso e consumato tra tutti, anche se per ovvi motivi il polline presenta i livelli più elevati di PAs e quindi può essere un problema per la sua qualità e la sua sicurezza per l'uomo. Da qui, l'invito agli apicoltori a sottoporre il polline prodotto dalle api ad un'analisi preventiva, qualora si sospetti che ci sia presenza di piante produttrici di PAs intorno agli apiari.
Gli esperti scientifici dell'Efsa hanno focalizzato l'attenzione esclusivamente sul miele, dichiarando che è l'alimento di origine animale maggiormente coinvolto, in particolare, nelle fasce più giovani della popolazione, nelle quali può avere effetti più che altro di tipo cumulativo laddove il consumo sia in quantità maggiori rispetto alla dose giornaliera raccomandata, con possibili effetti cronici ad insorgenza protratta nel tempo. Anche il tè e infusi di erbe possono dare preoccupazione per la salute umana.
Tutto questo ha portato all'emanazione del regolamento (UE) 2020/2040 (in applicazione dal 1° luglio 2022), che va ad integrare il regolamento (CE) 1881/2006 e che impone limiti (quello massimo di PAs è di 0,5 milligrammi per chilo) in alcuni alimenti: tè e tisane, polline e integratori a base di polline e alcune spezie.
Conclusioni
I PAs insaturi sono un gruppo eterogeneo di metaboliti a causa dei quali diversi prodotti di origine vegetale, nonché di origine animale, soprattutto quelli dell'alveare, possono risultare dannosi per la salute dell'uomo e dell'animale.
Alla luce dei numerosi studi effettuati, si rafforza l'importanza del monitoraggio di questi composti in vari alimenti, soprattutto nei prodotti dell'apicoltura; oltre alla cera d'api, di cui non si conoscono studi, sono urgenti approfondimenti sui mieli di melata, che fino ad adesso sono rimasti esclusi da questi monitoraggi.
Se la posizione di alcuni Paesi europei è addirittura quella di vietare il consumo alimentare di piante produttrici di PAs, si dovrebbe, invece, incentivare la ricerca, anche a livello nazionale.
Gli apicoltori devono porre attenzione alle zone di raccolta del polline, tenendo presente la stagionalità delle piante e i dati su vari pollini, come quello di Borragine selvatica, che evidenzia un alto contenuto di PAs, così come quelli di Viperina azzurra, evitando di esporre gli apiari in queste zone.
È essenziale, inoltre, un'opera di monitoraggio anche della flora autoctona e alloctona, mettendo su anche opere di eventuale eradicazione per ridurre al minimo l'esposizione di api e di animali al pascolo a piante potenziali produttrici di PAs. Non da ultimo, si deve continuare a lavorare in ottica "One Health" perché la salute dell'ambiente, quella degli animali e quella dell'uomo sono indissolubilmente legate tra loro: gli equilibri dell'ecosistema sono sempre più fragili a causa di specie "infestanti" che turbano la stabilità ambientale e tutto si ripercuote sugli animali, che vivono questi cambiamenti, e l'uomo, direttamente o indirettamente.
Bibliografia
• Bopprè M., Colegate SM., Edgar JA. (2005): Pyrrolizidine Alkaloids of Echium vulgare Honey Found in Pure Pollen. Journal of Agricultural and Food Chemistry; 53(3): 594-600.
• Debord C., Moing A., Roch L., Jacob D., Rolin D., Giraudeau P. (2017): Plant metabolism as studied by NMR spectroscopy. Progress in nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy; 102-103: 61-97.
• Edgar JA., Roeder E., Molyneux J. (2002): Honey from Plants Containing Pyrrolizidine Alkaloids: A Potential Threat to Health. Journal of Agricultural and Food Chemistry; 50(10): 2719-2730.
• EFSA (2011): Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed. EFSA Journal; 9(11): 1-134.
• EFSA (2016): Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population. EFSA Journal; 14 (8): 4572.
• EFSA (2017): Risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements. EFSA Journal; 15 (7): 4908.
• Fang C., Fernie AR., Luo J. (2019): Exploring the Diversity of Plant Metabolism. Trends in Plant Science; 24(1): 83-98.
• Hartmann T. (1999): Chemical ecology of pyrrolizidine alkaloids. Planta; 207(4): 483-495.
• Hoogenboom LAP, Mulder PPJ., Zeilmaker MJ., Van de Top HJ., Remmelink GJ., Brandon EFA., Klijnstra M., Meijer GAL., Schothorst R., Van Egmond HP (2011): Carry-over of pyrrolizidine alkaloids from feed to milk in dairy cows. Food Additives &Contaminants. Parte A, Volume 28: 359-372.
• Kast C., Dubecke A., Kilchenmann V., Bieri K., Bohlen M., Zoller O., Beckh G., Lullmann C. (2014): Analysis of Swiss honeys for pyrrolizidine alkaloids. J. Apicult. Res.; 53(1): 75-83.
• Lin G., Whang J., Li N., Li M., Gao H., Ji Y., Zhang F., Wang H., Zhou Y., Yang Y., Hong X.X., Jiang Z. (2011): Hepatic sinusoidal obstruction syndrome associated with consumption of Gynura segetum. J. Hepatol; 54: 666-673.
• Molineux RJ., Gardner DL., Collega SM., Edgar JA. (2011): Pyrrolizidine alkaloid toxicity in livestock: A paradigm for human poisoning? Food Additives & Contaminants. Parte A ;28: 293-307.
• Mulder PPJ., López Sánchez P., Questi A., Preiss-Weigert A., Castellari M., (2015): Occurrence of Pyrrolizidine Alkaloids in food. EFSA supporting pubblication 2015: EN-859.
• Mulder PPJ., De Witte S., Stoopen GM., Van der Meulen J., Van Wikselaar PG., Gruys E., Groot MJ., Hoogenboom LAP. (2016): Transfer of pyrrolizidine alkaloids from various herbs to eggs and meat in laying. Food Additives & Contaminants. Parte A; 33:1826-1839.
• Mulder PPJ., Lòpez P., Castelari M., Bodi D., Ronczka S., Preiss-Neigert A., Questi A. (2018): Occurrence of pyrrolizidine alkaloids in animal- and plant-derived food: results of a survey across Europe. Food Additives & Contaminants. Parte A; 35(1): 118-133.
• Mulder PPJ., Klijnstra MD., Goselink MA., Van Vuuren M., Cone WJ., Stoopen G., Hoogenboom LAP. (2020): Transfer of pyrrolizidine alkaloids from ragwort, common groundsel and viper's bugloss to milk from dairy cows. Food Additives & Contaminants. Parte A; 37: 1906-1921.
• Picron JF., Filippo F., Dubrull N., Hoeck E., Giraud N., Goscinny S., Vanhee C. (2021): Targeted LC-MS/MS combined with multilocus DNA metabarcoding as a combinatory approach to determine the amount and the source of pyrrolizidine alkaloids contamination in popular cooking herbs, seeds, spices and leafy vegetables. Food Additives & Contaminants.38:962-977.
• Schrenk D., Gao L., Lin G., Mahony C., Mulder PPJ., Peijnenburg A., Pfuhler S., Rietjens Im., Rutz L., Steinhoff B. (2020): Pyrrolizidine alkaloids in food and phytomedicine: Occurrence, exposure, toxicity, mechanisms, and risk assessment - A review. Food and Chemical Toxicology; 136: 11107.
• Van Wyk Be., Stander MA., Long H.S. (2017): Senecio angustifolius as the major source of pyrrolizidine alkaloid contamination of rooibos tea (Aspalathus linearis). South African Journal of Botany; 110: 124-131.
• Zhang W., Hual W., Zhang Y., Shen J., Tang X., Xie X., Fan H. (2017): Ultra-Performance Liquid Chromatography Hyphenated with Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometry for Simultaneous Determination of Necine-Core-Structure Pyrrolizidine Alkaloids in Crotalaria sessiliflora L. without all Corresponding Standards. Phytochemical analysis; 28(5): 365-373.
• Ziegler J., Facchini PJ. (2008): Alkaloid Biosynthesis: Metabolism and Trafficking. Annu. Rev. Plant Biol.; 59: 735-769.
Sitografia
• www.cnr.it
• www.gransassolagapark.it
• www.infoflora.ch/it/
• www.salute.gov.it
• www.verdeinfiore.it
• www.vitaminabee.it